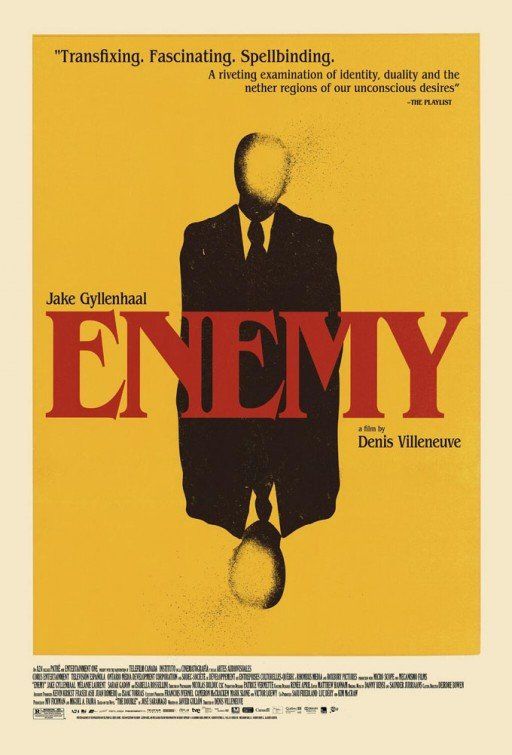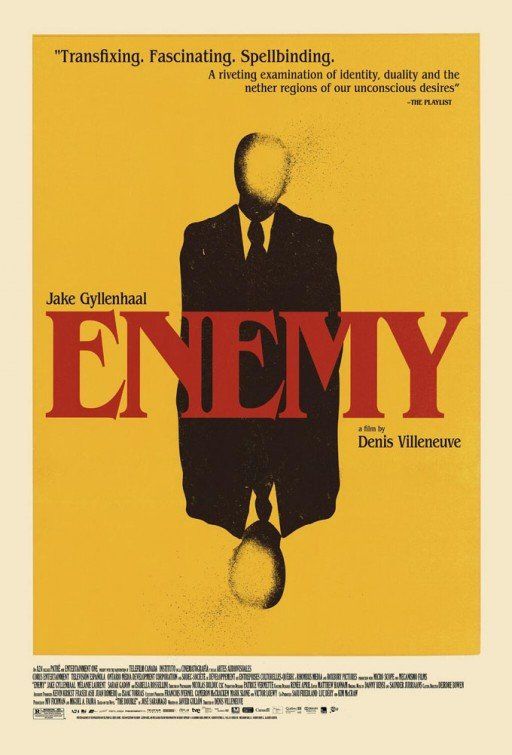
“Adam, un professore discreto, conduce una vita tranquilla con la
fidanzata Mary. Il giorno in cui scopre il suo sosia perfetto nella
persona di Anthony, un attore stravagante, sente una profonda
inquietudine. Inizia allora a osservare a distanza la vita di questo
uomo e della sua misteriosa moglie incinta. Poi Adam si mette a
immaginare i più fantastici scenari per sé e la propria coppia.” (dal
presskit).
Quella che segue non è una recensione, ma un'indagine interpretativa
del film in questione. Si suggerisce caldamente la lettura soltanto a
visione avvenuta, dal momento che l'indagine stessa, come ogni inchiesta
degna di questo nome, non sarebbe stata possibile omettendo snodi
centrali e passaggi salienti della trama. Detto altrimenti e più
chiaramente, ciò che segue si rivolge esclusivamente a chi abbia visto
il film e sia disposto ad avventurarsi - non dico a condividerla, non mi
spingerei a tanto - nella mia proposta interpretativa.

Quinto lungometraggio del cineasta canadese Denis Villeneuve,
Enemy conferma quanto ipotizzato nella recensione di
Prisoners: mentre quest’ultimo era un film spettacolare e pressoché anonimo al servizio della macchina hollywoodiana,
Enemy
è una produzione canadese indipendente e, soprattutto, una pellicola
inequivocabilmente personale (“il mio film più personale”, secondo le
dichiarazioni di Villeneuve). Presentato l’8 settembre al Toronto
International Film festival del 2013 a due soli giorni dalla proiezione
di
Prisoners e non distribuito in Italia,
Enemy è la libera trasposizione cinematografica del romanzo
L’uomo duplicato
(2002) di José Saramago (pubblicato in Italia prima da Einaudi e poi da
Feltrinelli con la traduzione di Rita Desti). Una trasposizione che lo
sceneggiatore Javier Gullón, naturalmente in sintonia con Villeneuve, ha
concepito all’insegna del tradimento letterale e della fedeltà
sostanziale. Al di là di alcune variazioni più o meno rilevanti
(spostamento geografico e cronologico, riduzione di alcune dinamiche
relazionali, finale diverso e aggiunta del motivo simbolico del ragno),
film e romanzo si specchiano difatti l’uno nell’altro pur mantenendo la
loro singolarità e la loro autonomia (cosa che del resto avviene anche
nella duplice vicenda raccontata).

Senza
dilungarsi eccessivamente sul lavoro di adattamento, corre tuttavia
l’obbligo di osservare che il romanzo di Saramago possiede una scrittura
palesemente anticinematografica: non tanto per la carenza di elementi
visivi o di una linea narrativa ben definita, quanto piuttosto per la
sinuosità dello stile letterario. Abolendo la distinzione tra discorso
diretto e indiretto e moltiplicando le contorsioni introspettive, lo
stile di Saramago poggia il suo baricentro proprio in questa fluidità
discorsiva che da una parte permette l’adozione di prospettive variabili
(si entra ed esce dalla testa dei personaggi con la stessa disinvoltura
con la quale, all’occorrenza, si sorvola l’universo descritto con uno
sguardo disincarnato) e, dall’altra, impregna l’intero dettato narrativo
della sensibilità tendente al farneticamento immaginativo del
protagonista. Non si tratta, a rigore, di un vero e proprio flusso di
coscienza, ma di un tappeto discorsivo apparentemente omogeneo che, se
osservato da vicino, si rivela composto da fili che lo attraversano a
diverse altezze e profondità. Malgrado la lunghezza del brano e a
esemplificazione di quanto appena detto, mette conto riportare
integralmente il passo del romanzo nel quale Maria da Paz (Mary/Mélanie
Laurent nel film), la fidanzata di Tertuliano Máximo Afonso (Adam/Jake
Gyllenhaal nel film), pronuncia la frase “Il caos è un ordine da
decifrare”, frase posta in esergo al romanzo e attribuita a un
immaginario
Libro dei contrari da Saramago e collocata subito dopo il prologo con la telefonata materna nel film di Villeneuve.
[Per non appesantire ulteriormente la lettura, il corposo passaggio si trova nel seguente paragrafo.]

“Si
sono separati lentamente, lei ha accennato un sorriso, lui ha accennato
un sorriso, ma noi sappiamo che Tertuliano Máximo Afonso ha un'altra
idea in testa, e cioè sottrarre alla vista di Maria da Paz, il prima
possibile, i fogli rivelatori, per cui non c'è da stupirsi che l'abbia
quasi spinta in cucina, Vai, vai a fare il caffè mentre io metto un po'
di ordine in questo caos, e allora è accaduto l'inaudito, come se non
desse importanza alle parole che le uscivano di bocca o come se non le
capisse completamente, lei ha mormorato, Il caos è un ordine da
decifrare, Cosa, cos'hai detto, domandò Tertuliano Máximo Afonso, che
aveva già la lista dei nomi in salvo, Che il caos è un ordine da
decifrare, Dove l'hai letto, da chi l'hai sentito, Mi è venuto in questo
momento, non credo di averlo mai letto, e, quanto ad averlo udito, sono
sicura di no, Ma come mai ti è venuta una frase del genere, Cos'ha di
speciale questa frase, Moltissimo, Non so, forse perché il mio lavoro in
banca si fa con cifre, e le cifre, quando si presentano mescolate,
confuse, possono apparire come elementi caotici a chi non le conosca,
eppure in loro c'è, latente, un ordine, in realtà credo che le cifre non
abbiano senso al di fuori di un qualsiasi ordine si dia loro, il
problema sta nel saperlo trovare, Qui non ci sono cifre, Ma c'è caos,
sei stato tu a dirlo, Un po' di video fuori posto, nient'altro, E anche
le immagini che vi sono dentro, le une accostate alle altre in modo da
raccontare una storia, cioè, un ordine, e i successivi caos che
formerebbero se le disperdessimo prima di riaccostarle per organizzare
storie diverse, e i successivi ordini che così otterremmo, sempre
lasciando dietro un caos ordinato, sempre avanzando in un caos da
ordinare, I segnali ideologici, ha detto Tertuliano Máximo Afonso, poco
sicuro che il riferimento venisse a proposito, Sì, i segnali ideologici,
se vuoi, Dai l'impressione di non credermi, Non importa se ti credo o
non ti credo, lo saprai tu cosa stai cercando, Ciò che stento a capire è
come tu abbia fatto questa scoperta, l'idea di un ordine contenuto nel
caos e che al suo interno può essere decifrato, Vuoi dire che in tutti
questi mesi, da quando è iniziata la nostra relazione, non mi hai mai
considerato abbastanza intelligente da avere delle idee, Macché, non si
tratta di questo, tu sei una persona molto intelligente, eppure, Eppure,
non hai bisogno di terminare, meno intelligente di te, e, chiaramente,
mi manca la buona preparazione di base, sono una povera impiegata di
banca, Smettila di ironizzare, non ho mai pensato che fossi meno
intelligente di me, voglio solo dire che questa tua idea è assolutamente
sorprendente, In me inaspettata, In un certo qual modo, sì, Lo storico
sei tu, ma credo di sapere che i nostri antenati hanno cominciato a
essere abbastanza intelligenti per avere delle idee solo dopo aver avuto
quelle idee che li resero intelligenti, Ora te ne vieni fuori anche con
i paradossi, passo da uno stupore all'altro, disse Tertuliano Máximo
Afonso, Prima che tu finisca per trasformarti in una statua di sale,
vado a fare il caffè, sorrise Maria da Paz, e mentre camminava nel
corridoio che la conduceva in cucina stava dicendo, Metti in ordine il
caos, Máximo, metti in ordine il caos.”, (pp. 88-89).

Ebbene,
il difficile lavoro di riduzione (non a caso porta questo nome)
compiuto da Gullón e Villeneuve è consistito essenzialmente nel ridurre
all’osso la tendenza verbigerante che di fatto costituisce la forza
espressiva del romanzo, oggettivando visivamente la duplice ossessione
del protagonista senza l’ausilio di voci interiori o delucidazioni
introspettive (e adesso sappiamo quanto siano importanti nell’economia
stilistica del libro), sopprimendo totalmente il dialogo intimo e
ininterrotto tra Tertuliano e il buon senso (autentico interlocutore non
interpellato e rumoroso disturbatore dei soliloqui dell'uomo duplicato)
e, infine, mantenendo in vita soltanto gli scambi verbali strettamente
necessari allo sviluppo e alla comprensione del disegno narrativo. Il
tutto senza frantumare o snaturare irrimediabilmente la struttura
profonda del testo di partenza, una struttura saldamente imperniata
sulla nozione di destino come forza inarrestabile che travolge le
imbelli esistenze umane, presentandosi sotto forma di pura e semplice
necessità: proprio quella necessità che, osserva Saramago, “è uno dei
nomi che prende il destino quando gli conviene camuffarsi.” (p. 242) . È
dunque solo a questo grado di profondità che la sovrapposizione tra
necessità e destino si lascia vedere distintamente e afferrare con
sicurezza. Ed è esattamente su questa riduzione all’osso - o meglio
proprio in virtù di essa - che Villeneuve ha innestato le due grandi
variazioni personali: l’ossessione del controllo collettivo
(rappresentato dalla ripetizione dello schema repressivo adottato dalle
dittature) e quella del controllo individuale esercitato dal subconscio,
incarnato precisamente e reiteratamente dalla madre-tarantola (non
sfugga la fonte d’ispirazione, riconosciuta dallo stesso Villeneuve, per
la rappresentazione dell’enorme ragno che incombe sulla metropoli
avvolta nello smog: la gigantesca scultura
Maman di Louise Bourgeois).

Se
è vero che entrambe le ossessioni, ancorché in maniera larvale o
disseminata, si trovano già nel libro, è altrettanto vero che, nel film,
queste si concretizzano figurativamente con impressionante incisività
(dai fili aerei del tram che, intersecandosi, disegnano una tela sospesa
ai graffiti seriali che, in stile Banksy, raffigurano silhouette di
impiegati-cloni, passando per gli schemi tentacolari disegnati sulla
lavagna dal professore di storia) e, soprattutto, assumono inflessioni
squisitamente personali. L’ossessione repressiva acquisisce inquietanti
tratti stereotipici, intrinsecamente legati al timore della ripetizione
sterile e dell’involuzione creativa del cineasta stesso, e
l’inquietudine per l’esigente autoritarismo materno si converte nella
minacciosa e pervasiva presenza di ragni e ragnatele, caricandosi così
di forti e allarmanti risonanze psichiche (peraltro totalmente assenti
nella scultura di Louise Bourgeois, nella quale la madre-ragno
rappresenta esclusivamente qualità positive come intelligenza, pazienza,
utilità, protezione e via seguitando). Villeneuve non mente quando
sostiene che il modo migliore per definire
Enemy è
quello di considerarlo come un “documentario sul subconscio di Jake
Gyllenhaal”, ovviamente riferendosi al doppio personaggio da lui
interpretato, e quando aggiunge che il film non è altro che
“l’esplorazione dell’intimità maschile”, calcando ulteriormente la mano
sulle dinamiche intrapsichiche messe in scena dalla pellicola.

Del resto è lo stesso Villeneuve,
in un'intervista rilasciata a una testata canadese,
a fornire una chiave di lettura psichicamente orientata: "È una storia
molto semplice: è un uomo che decide di lasciare l'amante e tornare
dalla moglie incinta. E noi vediamo la storia dal punto di vista del suo
subconscio". Il che equivale a dire che si tratta non tanto della
"storia di un uomo che…", quanto, più precisamente, della "storia del
subconscio di un uomo che…". L'intero film, difatti, è costruito come
un enigma, un puzzle o, più precisamente, come un
mind game movie secondo la definizione formulata da Thomas Elsaesser e Malte Hagener in
Teoria del film (Einaudi, Torino, 2009): "Il principio strutturale dei
mind game movies
consiste nel trascinare gli spettatori nel mondo del protagonista, e
ciò in un modo che sarebbe impossibile se la narrazione guadagnasse
distanza (…)", pp. 171-172. Una pellicola, insomma, la cui proprietà
principale consiste nel giocare con lo spettatore e la sua percezione
della realtà, ovviamente quella offerta dal film stesso: non è fortuito
che Villeneuve indichi tra i suoi titoli preferiti film-enigma come
Mulholland Drive,
2001: Odissea nello Spazio o
L'inquilino del terzo piano,
film che propongono immagini potenti sul piano emotivo e che, al
contempo, ingaggiano gli spettatori nella ricerca di un significato che,
naturalmente, non sarà mai lo stesso per ciascuno di loro. Quella
tessuta da
Enemy, insomma, è una ragnatela di segni
(chiedo venia per l’immagine scontata) che, al di là del suo potere
d'irretimento fascinatorio, suggerisce una meticolosa elaborazione
psichica e reclama la formulazione di un'ipotesi interpretativa
eminentemente mentale.

Impossibile,
difatti, non scorgere nel personaggio duplicato interpretato da
Gyllenhaal con finissima sensibilità attoriale e nella figura materna
incarnata da Isabella Rossellini la rappresentazione delle tre istanze
psichiche di un solo individuo: Es, Io e Super-Io. Se l’identificazione
tra Anthony (attore infedele e lussurioso) ed Es è fin troppo pacifica,
quella tra il bonario e monotono insegnante di storia Adam e l’Io,
nonché quella tra la severa madre e il Super-Io, non sembra presentare
difficoltà sensibilmente maggiori (basti pensare all’eloquente e
perentorio dialogo nella casa-atelier della genitrice). Tuttavia il
Super-Io impregna di sé, per proprietà transitiva, la maternità in
quanto tale. Nel prologo, subito dopo la telefonata della madre, la
presenza apparentemente immotivata di Helen (Sarah Gadon) al sesto mese
di gravidanza, seduta sul letto e con lo sguardo rivolto verso la
camera, non lascia spazio a dubbi: le due donne condividono lo stesso
luogo psichico e le medesime funzioni mentali, vale a dire la
disposizione all’ordine e la propensione al controllo (Helen,
diffidente, fruga nei pantaloni del marito mentre lui dorme e, senza
dire niente al coniuge, non si fa scrupolo di andare sul posto di lavoro
del fantomatico sosia). Un’identificazione, quella tra le due donne,
che si rinsalda nel prefinale, quando Helen, esplicita portavoce della
madre, ricorda al marito che lei ha telefonato e che lui dovrebbe
richiamarla: preludio più che comprensibile alla sconcertante
trasfigurazione terminale in cui è Helen stessa a tramutarsi in
tarantola, chiudendo definitivamente il cerchio superegoico femminile.

Dunque, alla luce di queste considerazioni, che cosa racconta
Enemy?
Senza dubbio ciò che asserisce Villeneuve (la storia del subconscio di
un uomo che lascia l’amante e decide di tornare dalla moglie incinta),
ma con la decisiva precisazione che per portare a termine il suo
proposito uccide il proprio Es e si dà completamente in pasto al
Super-Io. Lo spaventoso epilogo, nel quale Helen assume improvvisamente
le fattezze della tarantola-madre ci mostra le conseguenze di questa
soppressione autolesionistica: la mutilazione psichica praticata dal
senso di colpa (l’uomo si scusa apertamente con la moglie,
abbandonandosi completamente a lei) lo priva letteralmente del suo Es
(alla richiesta di restare formulata da Helen, Adam visualizza, o meglio
genera mentalmente, l’incidente in cui periscono Anthony e Mary).
Sicché, quando si trova nuovamente in mano la possibilità della
trasgressione (la chiave del club erotico nel quale lo abbiamo visto
entrare all'inizio del film), non dispone più della complicità del suo
Es, non può più effettuare la metamorfosi in Anthony: ormai è solo col
suo Super-Io. L'ipotesi trasgressiva, al contrario e conseguentemente
alla mutilazione avvenuta, scatena inevitabilmente la metamorfosi
inversa: trasfigura Helen in tarantola, oggettivando plasticamente la
sola istanza mentale con la quale il suo Io è - e sarà - costretto a
confrontarsi. Lo sguardo conclusivo di Adam, intriso di rassegnazione
anziché di stupefatto terrore, sigilla ermeticamente il suo orizzonte
mentale e decreta la sua resa incondizionata. D’ora in poi l’insorgenza
del pensiero trasgressivo produrrà, per contraccolpo e in mancanza di
un’istanza che lo prenda in carico, la visione intimidita della
tarantola-madre-moglie (paradossalmente a essere spaventato è proprio il
gigantesco aracnide, segno che è perfettamente al corrente delle
intenzioni dell’uomo).
Ricapitolando: sovrapposizione di necessità e
destino da una parte (vero e proprio nucleo creativo del cinema di
Villeneuve) e declinazione marcatamente intrapsichica delle dinamiche
narrative dall’altra (nel libro Helena non è incinta e il finale
differisce radicalmente, spostando l'intera narrazione più sul versante
surreale che su quello mentale). Sono questi gli aspetti che il cineasta
canadese sviluppa e interpreta personalmente nella trasposizione
filmica.

Ispirandosi
alla scabra essenzialità dell'architettura brutalista, un'architettura
che privilegia volumi con cemento a vista e pone l’accento sulle
nervature strutturali (il college nel quale insegna Adam è in realtà
l'University of Toronto Scarborough Campus, uno dei numerosi esempi di
brutalismo presenti nella metropoli canadese), l'estetica di
Enemy
possiede un'impronta tecnicamente granitica che consolida la continuità
visiva (fotografia ambrata, movimenti di macchina lenti e misurati,
illuminazione giallastra) e che, grazie alle frequenti riprese aeree,
ricava da Toronto una spazialità massiccia e stilizzata al tempo stesso.
“Toronto è una città molto cerebrale, è come un'idea”,
ha affermato Villeneuve chiamando in causa
Crash di David Cronenberg e
Last Night di Don McKellar, i due soli titoli che a suo avviso hanno reso giustizia alla città. In
Enemy
questa affermazione si fa vigorosamente cinema, traendo il massimo
partito dalla singolarità architettonica e urbanistica della metropoli
canadese (troppo spesso usata per simulare scenari statunitensi),
qualificandola integralmente come luogo mentale (non un solo spazio è
scevro da risonanze psichiche) e, infine, facendo dell'intera vicenda il
confronto implacabile tra un uomo e una città di vetro e cemento
(l’inquadratura iniziale è una panoramica orizzontale sullo skyline di
Toronto e i bellissimi titoli di coda passano in rassegna le prospettive
e i giochi volumetrici disegnati dai grattacieli che torreggiano nella
metropoli). Insieme a
Polytechnique, altra pellicola incentrata sul confronto tra uomo e spazio, il miglior film del cineasta canadese.
Pubblicata su www.spietati.it.
 “Nell’antica Roma, la Suburra era il quartiere dove il potere e la
criminalità segretamente si incontravano. Dopo oltre duemila anni, quel
luogo esiste ancora. Perché oggi, forse più di allora, Roma è la città
del potere: quello dei grandi palazzi della politica, delle stanze
affrescate e cariche di spiritualità del Vaticano e quello, infine,
della strada, dove la criminalità continua da sempre a cercare la via
più diretta per imporre a tutti la propria legge. Il film è la storia di
una grande speculazione edilizia, il Water-front, che trasformerà il
litorale romano in una nuova Las Vegas. Per realizzarla servirà
l’appoggio di Filippo Malgradi (Pierfrancesco Favino), politico corrotto
e invischiato fino al collo con la malavita, di Numero 8 (Alessandro
Borghi), capo di una potentissima famiglia che gestisce il territorio e,
soprattutto, di Samurai (Claudio Amendola), il più temuto
rappresentante della criminalità romana e ultimo componente della Banda
della Magliana. Ma a generare un inarrestabile effetto domino capace di
inceppare definitivamente questo meccanismo saranno, in realtà, dei
personaggi che vivono ai margini dei giochi di potere come Sebastiano
(Elio Germano), un PR viscido e senza scrupoli, Sabrina un’avvenente
escort (Giulia Elettra Gorietti), Viola (Greta Scarano) la fidanzata
tossicodipendente di Numero 8 e Manfredi (Adamo Dionisi) il capoclan di
una pericolosa famiglia di zingari.” (dal presskit).
“Nell’antica Roma, la Suburra era il quartiere dove il potere e la
criminalità segretamente si incontravano. Dopo oltre duemila anni, quel
luogo esiste ancora. Perché oggi, forse più di allora, Roma è la città
del potere: quello dei grandi palazzi della politica, delle stanze
affrescate e cariche di spiritualità del Vaticano e quello, infine,
della strada, dove la criminalità continua da sempre a cercare la via
più diretta per imporre a tutti la propria legge. Il film è la storia di
una grande speculazione edilizia, il Water-front, che trasformerà il
litorale romano in una nuova Las Vegas. Per realizzarla servirà
l’appoggio di Filippo Malgradi (Pierfrancesco Favino), politico corrotto
e invischiato fino al collo con la malavita, di Numero 8 (Alessandro
Borghi), capo di una potentissima famiglia che gestisce il territorio e,
soprattutto, di Samurai (Claudio Amendola), il più temuto
rappresentante della criminalità romana e ultimo componente della Banda
della Magliana. Ma a generare un inarrestabile effetto domino capace di
inceppare definitivamente questo meccanismo saranno, in realtà, dei
personaggi che vivono ai margini dei giochi di potere come Sebastiano
(Elio Germano), un PR viscido e senza scrupoli, Sabrina un’avvenente
escort (Giulia Elettra Gorietti), Viola (Greta Scarano) la fidanzata
tossicodipendente di Numero 8 e Manfredi (Adamo Dionisi) il capoclan di
una pericolosa famiglia di zingari.” (dal presskit).  Esistono almeno due modi di considerare Suburra:
il primo - che rispecchia in maniera ragionevolmente fedele
l’atteggiamento di chi scrive - consiste nel rimanere sostanzialmente
indifferenti al cinema squadernato dal film: cinema bullo e
romanocentrico, roboante e pieno zeppo di facce note, sempre uguale a se
stesso perché sempre un po’ diverso. Un cinema che mette in scena lo
spettacolo della morte ma perfettamente al riparo dalla morte dello
spettacolo. Un cinema che racconta il racconto della corruzione
pretendendo di raccontare la corruzione stessa. Cinema della
mistificazione sistematica, della simulazione invulnerabile: anziché
rielaborare la tragedia in narrazione, la spettacolarizza compiacendosi
del proprio segno da farsa grottesca. Un cinema in cui ogni elemento è
assoggettato e docilmente obbediente al primato della convenzione e
della resa effettistica: celebrazione impeccabile di una credibilità
esclusivamente stereotipata e caricaturale. Cinema dell’overacting anche
quando - soprattutto quando - la recitazione assume pose trattenute e
interiorizzate (vedasi Amendola). Cinema del dialetto capitolino come
indice di veracità, cinema che scimmiotta modelli americani (Scorsese,
Mann, Il cattivo tenente
di Abel Ferrara) assimilando stilemi seriali e scaraventandoli in
un’impaginazione da graphic novel. Cinema di dialoghi fieramente
folkloristici, musiche di rinforzo e montaggi alternati di inossidabile
dualismo (carezza e bacio al figlio dormiente, incatenamento e lancio
del cadavere zavorrato). Cinema totalmente innocuo, infine, perché
lascia lo spettatore esattamente dove e come si trovava prima di essere
sequestrato per 130’. Risultato? L'indifferenza più imperturbabile.
Questo l’atteggiamento di chi non accetta le regole del gioco postulate
dal film di Stefano Sollima.
Esistono almeno due modi di considerare Suburra:
il primo - che rispecchia in maniera ragionevolmente fedele
l’atteggiamento di chi scrive - consiste nel rimanere sostanzialmente
indifferenti al cinema squadernato dal film: cinema bullo e
romanocentrico, roboante e pieno zeppo di facce note, sempre uguale a se
stesso perché sempre un po’ diverso. Un cinema che mette in scena lo
spettacolo della morte ma perfettamente al riparo dalla morte dello
spettacolo. Un cinema che racconta il racconto della corruzione
pretendendo di raccontare la corruzione stessa. Cinema della
mistificazione sistematica, della simulazione invulnerabile: anziché
rielaborare la tragedia in narrazione, la spettacolarizza compiacendosi
del proprio segno da farsa grottesca. Un cinema in cui ogni elemento è
assoggettato e docilmente obbediente al primato della convenzione e
della resa effettistica: celebrazione impeccabile di una credibilità
esclusivamente stereotipata e caricaturale. Cinema dell’overacting anche
quando - soprattutto quando - la recitazione assume pose trattenute e
interiorizzate (vedasi Amendola). Cinema del dialetto capitolino come
indice di veracità, cinema che scimmiotta modelli americani (Scorsese,
Mann, Il cattivo tenente
di Abel Ferrara) assimilando stilemi seriali e scaraventandoli in
un’impaginazione da graphic novel. Cinema di dialoghi fieramente
folkloristici, musiche di rinforzo e montaggi alternati di inossidabile
dualismo (carezza e bacio al figlio dormiente, incatenamento e lancio
del cadavere zavorrato). Cinema totalmente innocuo, infine, perché
lascia lo spettatore esattamente dove e come si trovava prima di essere
sequestrato per 130’. Risultato? L'indifferenza più imperturbabile.
Questo l’atteggiamento di chi non accetta le regole del gioco postulate
dal film di Stefano Sollima. Il
secondo modo, legittimo quanto il primo e forte degli stessi titoli di
nobiltà (la facoltà di incanaglirsi liberamente è garantita dalla carta
dei diritti dello spettatore), risiede nell’accettare più o meno
consapevolmente le regole del gioco - altri le chiamerebbero senza
esitazioni regole di genere - e godersi lo spettacolo sontuosamente
allestito da Sollima, Petraglia, Rulli, Bonini e De Cataldo, abilmente
spalleggiati dalla poderosa fotografia di Paolo Carnera (illuminazione e
cromatismi di indiscutibile virtuosismo), dalle certosine scenografie
di Paki Meduri (dall’emiciclo parlamentare alle stanze vaticane,
passando per ville al neon o arredi sfarzosamente eclettici) e dal
montaggio incalzante di Patrizio Marone (l’orchestrazione visiva della
sparatoria nel supermercato, l’implacabilità della carneficina nelle
baracche dei pescatori). Un atteggiamento, questo, che vedrà
plausibilmente inverarsi in Suburra un affresco nero
di sconcertante attualità in grado di reinventare la cinecriminalità
italiana, trasportando sul grande schermo l’irruenza ritmica della
migliore fiction e trascinando lo spettatore, con tecnica di rara
maestria ma sempre al servizio dell’emozione e dell’intensità
drammatica, nel melmoso abisso di un’Apocalisse che non salva niente e
nessuno. Un universo marcio e dai giorni contati nel quale Favino,
Germano e Amendola si superano letteralmente in prove attoriali da
applausi a scena aperta, peraltro affiancati da impressionanti
interpreti della nuova generazione quali Alessandro Borghi, Giacomo
Ferrara, Giulia Elettra Gorietti e, soprattutto, Greta Scarano, che con
la sua Viola dà vita a un personaggio indomito e tormentato capace di
riparare i torti subiti con una vendicatività tanto furente quanto
inesorabile. Una guerra senza quartiere e senza esclusione di colpi,
infine, irrobustita dalle sonorità dream pop e shoegaze degli M83. Se si
sta al gioco, insomma, ci si gode lo spettacolo di questa accattivante
“Settimana dell’Apocalisse” con voluttuosa e più che soddisfacente
adesione.
Il
secondo modo, legittimo quanto il primo e forte degli stessi titoli di
nobiltà (la facoltà di incanaglirsi liberamente è garantita dalla carta
dei diritti dello spettatore), risiede nell’accettare più o meno
consapevolmente le regole del gioco - altri le chiamerebbero senza
esitazioni regole di genere - e godersi lo spettacolo sontuosamente
allestito da Sollima, Petraglia, Rulli, Bonini e De Cataldo, abilmente
spalleggiati dalla poderosa fotografia di Paolo Carnera (illuminazione e
cromatismi di indiscutibile virtuosismo), dalle certosine scenografie
di Paki Meduri (dall’emiciclo parlamentare alle stanze vaticane,
passando per ville al neon o arredi sfarzosamente eclettici) e dal
montaggio incalzante di Patrizio Marone (l’orchestrazione visiva della
sparatoria nel supermercato, l’implacabilità della carneficina nelle
baracche dei pescatori). Un atteggiamento, questo, che vedrà
plausibilmente inverarsi in Suburra un affresco nero
di sconcertante attualità in grado di reinventare la cinecriminalità
italiana, trasportando sul grande schermo l’irruenza ritmica della
migliore fiction e trascinando lo spettatore, con tecnica di rara
maestria ma sempre al servizio dell’emozione e dell’intensità
drammatica, nel melmoso abisso di un’Apocalisse che non salva niente e
nessuno. Un universo marcio e dai giorni contati nel quale Favino,
Germano e Amendola si superano letteralmente in prove attoriali da
applausi a scena aperta, peraltro affiancati da impressionanti
interpreti della nuova generazione quali Alessandro Borghi, Giacomo
Ferrara, Giulia Elettra Gorietti e, soprattutto, Greta Scarano, che con
la sua Viola dà vita a un personaggio indomito e tormentato capace di
riparare i torti subiti con una vendicatività tanto furente quanto
inesorabile. Una guerra senza quartiere e senza esclusione di colpi,
infine, irrobustita dalle sonorità dream pop e shoegaze degli M83. Se si
sta al gioco, insomma, ci si gode lo spettacolo di questa accattivante
“Settimana dell’Apocalisse” con voluttuosa e più che soddisfacente
adesione. Un
terzo atteggiamento, puramente ipotetico ma verosimilmente più
interessante dei due sopra sbozzati, si lascia infine sollecitare (e
solleticare) dalla massiccia presenza di segnali necrotici che, in
maniera più o meno deliberata, costellano il corpo e i corpi di Suburra.
Una fitta serie di ferite mortali inferte sul tessuto filmico che,
colpendo senza pietà i corpi depositari di tradizioni cinematografiche e
pratiche consolidate dell’audiovisivo, fanno piazza pulita delle
concezioni incarnate da questi ectoplasmi in carne e celluloide. Si
tratta di una lettura sintomatica che, praticando una sorta di
necroscopia sulla salma Suburra, rileva una lunga lista
di cadaveri eccellenti. Innanzitutto il cinema italiano dagli anni ’80
in poi, sacrificato nella doppia eliminazione di Antonello Fassari e
Claudio Amendola: il primo suicida poiché incapace di comunicare col
figlio Sebastiano/Germano (il dialogo tra i due è un campionario di
incomprensioni più che un passaggio di testimone: “È stato uno sbaglio
farti venire qui”, sussurra rassegnato Fassari), il secondo giustiziato
con determinazione punitiva da Viola/Scarano, che liquida il tentativo
di patteggiare in extremis del Samurai, palese residuo di una
cinecriminalità ormai normalizzata, con un sarcastico “La prossima
volta!”. Altro cadavere: le serie televisive, freddate con l’esecuzione
di Numero 8/Borghi da parte di quello stesso cinema, il
Samurai/Amendola, che soccomberà davanti all’unica sopravvissuta di
questa ecatombe cinematografica. Il regolamento di conti non risparmia
il cinema italiano contemporaneo, esemplarmente rappresentato dal
binomio Favino/Germano: un cinema lasciato in vita soltanto formalmente
ma severamente offeso sia sotto il profilo fisico (nell’impietosa e
brutale animalità di Filippo Malgradi e nella repellente viscidità di
Sebastiano) che sotto quello morale (Favino puttaniere strafatto e
politico senza scrupoli, il giovane favoloso Germano convertito alle
delizie del lenocinio e della delazione). Un bodycount cinematografico
che, avvolto nel sudario di una recitazione smaccatamente necrofila e
marionettistica, fa di Suburra uno slasher sotto
mentite spoglie: Viola, finalmente trasfigurata in eroina da graphic
novel, esce dall’inquadratura lasciando dietro di sé il vuoto, irrorato
di pioggia e sangue.
Un
terzo atteggiamento, puramente ipotetico ma verosimilmente più
interessante dei due sopra sbozzati, si lascia infine sollecitare (e
solleticare) dalla massiccia presenza di segnali necrotici che, in
maniera più o meno deliberata, costellano il corpo e i corpi di Suburra.
Una fitta serie di ferite mortali inferte sul tessuto filmico che,
colpendo senza pietà i corpi depositari di tradizioni cinematografiche e
pratiche consolidate dell’audiovisivo, fanno piazza pulita delle
concezioni incarnate da questi ectoplasmi in carne e celluloide. Si
tratta di una lettura sintomatica che, praticando una sorta di
necroscopia sulla salma Suburra, rileva una lunga lista
di cadaveri eccellenti. Innanzitutto il cinema italiano dagli anni ’80
in poi, sacrificato nella doppia eliminazione di Antonello Fassari e
Claudio Amendola: il primo suicida poiché incapace di comunicare col
figlio Sebastiano/Germano (il dialogo tra i due è un campionario di
incomprensioni più che un passaggio di testimone: “È stato uno sbaglio
farti venire qui”, sussurra rassegnato Fassari), il secondo giustiziato
con determinazione punitiva da Viola/Scarano, che liquida il tentativo
di patteggiare in extremis del Samurai, palese residuo di una
cinecriminalità ormai normalizzata, con un sarcastico “La prossima
volta!”. Altro cadavere: le serie televisive, freddate con l’esecuzione
di Numero 8/Borghi da parte di quello stesso cinema, il
Samurai/Amendola, che soccomberà davanti all’unica sopravvissuta di
questa ecatombe cinematografica. Il regolamento di conti non risparmia
il cinema italiano contemporaneo, esemplarmente rappresentato dal
binomio Favino/Germano: un cinema lasciato in vita soltanto formalmente
ma severamente offeso sia sotto il profilo fisico (nell’impietosa e
brutale animalità di Filippo Malgradi e nella repellente viscidità di
Sebastiano) che sotto quello morale (Favino puttaniere strafatto e
politico senza scrupoli, il giovane favoloso Germano convertito alle
delizie del lenocinio e della delazione). Un bodycount cinematografico
che, avvolto nel sudario di una recitazione smaccatamente necrofila e
marionettistica, fa di Suburra uno slasher sotto
mentite spoglie: Viola, finalmente trasfigurata in eroina da graphic
novel, esce dall’inquadratura lasciando dietro di sé il vuoto, irrorato
di pioggia e sangue.